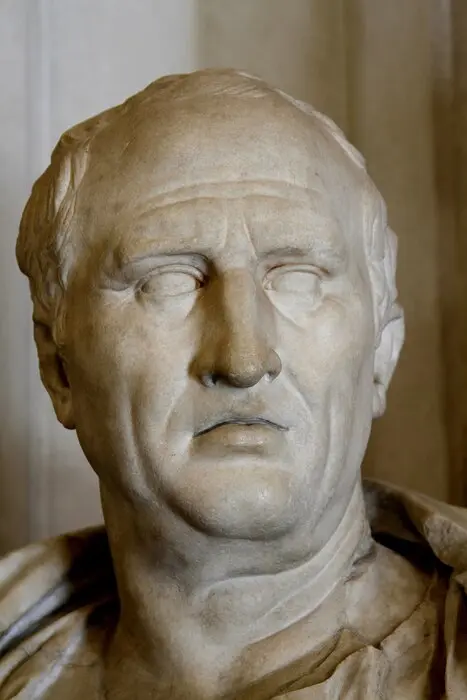Il Brutus, o De claris oratoribus, è un'opera di Marco Tullio Cicerone. Si tratta di un dialogo scritto nel 46 a.C. che ha come tema centrale la storia e la teoria dell'eloquenza a Roma. È un trattato di grande importanza per la retorica e per la comprensione del pensiero di Cicerone sull'oratoria.
1. Contesto e struttura del "Brutus"
L'opera si presenta come un dialogo tra Cicerone stesso, Attico (suo amico e storico), e Marco Giunio Bruto (lo stesso che avrebbe partecipato all'uccisione di Cesare). Si svolge in tre parti principali:
- Elogio dell'eloquenza: Cicerone analizza il ruolo dell'oratoria nella politica e nella società romana.
- Storia dell'oratoria romana: una rassegna degli oratori più celebri di Roma, dalle origini fino al presente.
- Discussione sull'eloquenza contemporanea: Cicerone riflette sul declino dell'oratoria rispetto ai tempi passati.
2. Il ruolo di Bruto nell'opera
Bruto, nel dialogo, rappresenta un interlocutore serio e riflessivo. Cicerone, che aveva grande stima di lui, lo include nell’opera per sottolineare il valore dell'eloquenza come strumento politico.
Elogio di Bruto
Cicerone, nella dedica iniziale, scrive:
"Nam tu es ille, Brute, qui eloquentiam non modo a tuis maioribus non alienam, sed ab omni genere ingenuarum artium ac virtutum seiunctam putes."
("Tu, Bruto, sei colui che non solo ritieni che l’eloquenza non sia estranea ai tuoi antenati, ma che non debba essere separata da alcuna nobile arte o virtù.")
Cicerone elogia Bruto come un uomo ideale, capace di combinare virtù, arte e oratoria.
3. Citazioni chiave dal "Brutus"
Sulla definizione di oratore
Cicerone descrive l’oratore perfetto:
"Orator est vir bonus dicendi peritus."
("L'oratore è un uomo virtuoso esperto nell'arte del parlare.")
Questa frase riflette il legame tra moralità e capacità retorica.
Sull'importanza dell'eloquenza nella politica
"Nam sine hac nobilitas ipsa obscura ac sordida est et saepe abiecta; contra ea, quae per hanc adipiscuntur, ornantur et illustrantur."
("Senza l’eloquenza, persino la nobiltà appare oscura e ignobile, mentre ciò che si ottiene grazie ad essa è reso nobile e luminoso.")
Cicerone enfatizza il ruolo fondamentale dell’eloquenza per il successo politico e personale.
Sulla storia dell’oratoria romana
Cicerone ripercorre i principali oratori del passato e critica il declino contemporaneo:
"Neque vero habuit post hominum memoriam Roma tam claram ac nobilem oratorum prolem quam haec nostra aetas."
("E invero Roma, a memoria d’uomo, non ebbe mai una generazione di oratori tanto chiara e nobile come quella della nostra epoca.")
Un giudizio che dimostra l’orgoglio di Cicerone per la sua generazione, ma anche la sua nostalgia per i "grandi" oratori del passato.
4. Conclusione del "Brutus"
L'opera si conclude con un appello alla preservazione e al rinnovamento dell’eloquenza, un valore che Cicerone considera essenziale per la civiltà romana.
"Quod si haec ars et facultas dicendi tantam habet, quantam ego sentio, utilitatem, operam detis, quaeso, ut ea nosmet ipsi digni, qui dicamus, esse videamur."
("Se quest’arte e questa abilità nel parlare ha tanto valore quanto io credo, vi prego di impegnarvi affinché noi stessi sembriamo degni di essa.")