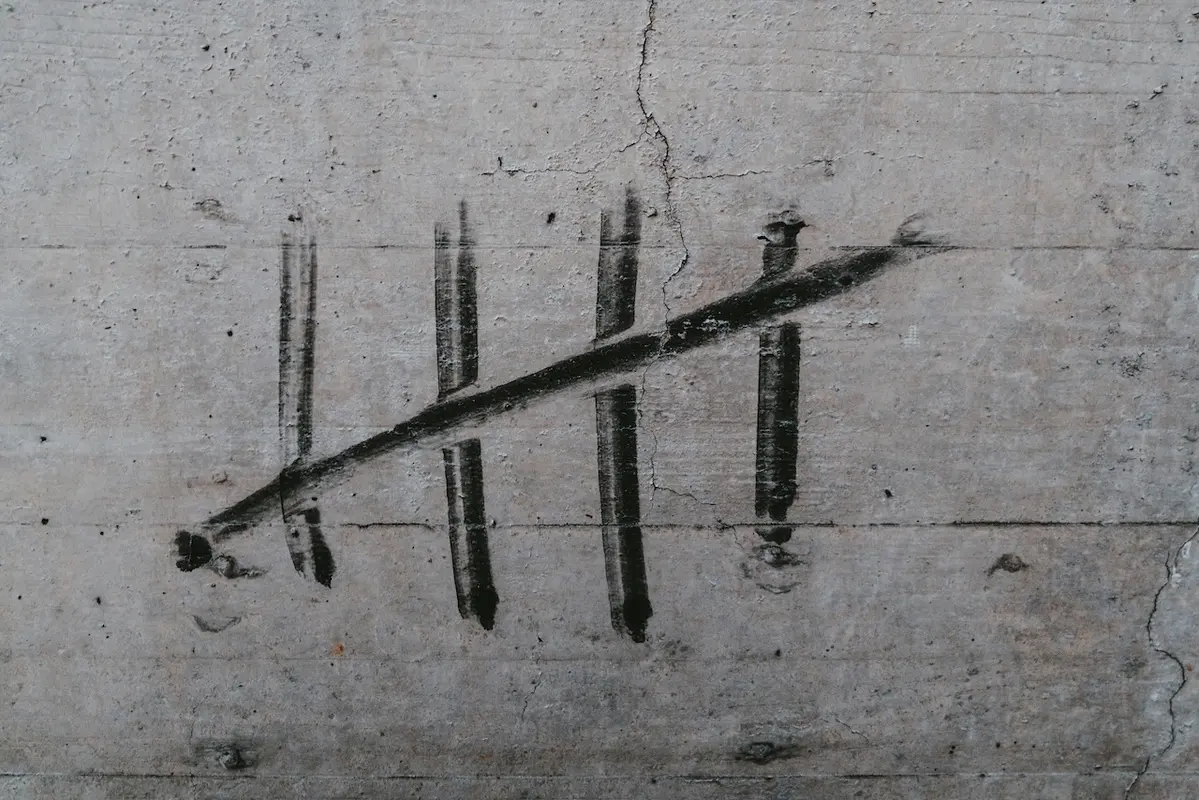Mimesis (1946) è il capolavoro con cui Erich Auerbach ricostruisce, attraverso una serie di letture ravvicinate, la storia di come la letteratura occidentale ha rappresentato la realtà. Scritto in esilio a Istanbul durante la Seconda guerra mondiale, il libro combina filologia, storia delle idee e critica stilistica per mostrare come il quotidiano, il concreto e il “serio” siano entrati progressivamente nella sfera del rappresentabile.
Tesi centrale
Al cuore di Mimesis c’è l’idea che la tradizione occidentale passi da modelli di rappresentazione gerarchici e stilisticamente separati (alti vs bassi) a una mescolanza degli stili in cui il quotidiano può diventare oggetto di trattamento serio. Questo movimento, preparato dalla Bibbia e dalla cultura cristiana, culmina nel realismo moderno, capace di dare dignità narrativa a ogni strato sociale, a ogni registro linguistico, a ogni dettaglio concreto.
Metodo: letture ravvicinate “storicamente situate”
Auerbach procede per capitoli autonomi: ogni capitolo parte da un brano esemplare e ne analizza sintassi, lessico, ritmo, registri e sottintesi storici. L’unità del libro nasce non da un sistema teorico astratto, ma dalla comparazione di stili in momenti chiave della tradizione occidentale, dal mondo antico al Novecento.
Due stili originari: Omero e la Bibbia
- Omero: stile chiaro, continuo, esplicativo; tutto è portato alla luce del presente del racconto. La realtà omerica è ampia, descritto ogni dettaglio, ma raramente allusiva o carica di profondità storica.
- Bibbia (Genesi): stile franto, ellittico, carico di reticenze e tensione. Gli eventi minimi assumono serietà assoluta perché inseriti in un orizzonte teologico: è l’origine del sermo humilis trattato in senso alto.
Questo contrasto iniziale prepara la tesi di lungo periodo: la tradizione cristiana rompe la rigida separazione antica tra stili e incoraggia il trattamento serio del quotidiano.
Il cristianesimo, il sermo humilis e la mescolanza degli stili
Nel Medioevo latino e romanzo il “basso” (lingua comune, vite ordinarie) diventa veicolo di contenuti alti. Auerbach legge in questa dinamica il presupposto del realismo: la dignità estetica del quotidiano. Dante, con la sua Commedia, è decisivo: innalza lingua e soggetti diversi, accostando registro sublime, comico e tecnico in una struttura totalizzante.
Capitoli-chiave e traiettorie
- Agostino e la patristica: consolidano il valore del quotidiano nella storia della salvezza.
- Dante: totalità del reale, individualità storica dei personaggi, polifonia di registri.
- Rabelais: il corpo grottesco e il mondo “basso” come energia conoscitiva.
- Cervantes: il gioco tra idealità cavalleresca e realtà prosaica apre al romanzo moderno.
- Realismo ottocentesco (Stendhal, Balzac, Flaubert): rappresentazione sociale, dettaglio significativo, narratore attento ai meccanismi economici e psicologici.
- Modernismo (Proust, Woolf): temporalità interiore, memoria e coscienza come luoghi della realtà; il quotidiano diventa microcosmo di profondità storica.
Il “figuralismo” come orizzonte interpretativo
Sebbene il saggio Figura sia distinto da Mimesis, la nozione di realismo figurale aiuta a comprendere il libro: gli eventi storici sono letti come figure che preannunciano e si compiono in altri eventi, creando un nesso tra il prosaico e l’assoluto. Questo schema, innervato nella cultura cristiana, legittima il serio nel quotidiano e prepara la commistione degli stili.
Lingua, stile, società
Auerbach intreccia forma e storia sociale: cambiamenti di sintassi, punti di vista, registri e lessici rispecchiano trasformazioni delle strutture politiche e della vita comune (urbanizzazione, mercato editoriale, nascita del pubblico borghese). La stilistica non è formalismo: è un modo di leggere i testi come indizi di realtà storica.
Una storia “dal basso” del realismo
La forza di Mimesis sta nel mostrare come il particolare concreto—un gesto, un oggetto, una stanza—possa rivelare strutture profonde. Il “dettaglio pregnante” distingue il realismo moderno dalla mera cronaca: non accumulo, ma selezione significativa che dà spessore temporale e sociale al racconto.
Attualità critica
- Comparatistica: modello di lettura transnazionale fondato su testi e non su schemi astratti.
- Metodo lento: difesa della close reading come pratica storica, non solo formale.
- Pluralità dei registri: utile per comprendere narrazioni contemporanee che ibridano generi e lingue (dal reportage narrativo alla serialità).
Obiezioni e limiti discussi
- Teleologia implicita verso il realismo moderno; rischio di sottovalutare tradizioni non occidentali.
- Selezione di testi inevitabilmente parziale; alcune autrici e letterature restano ai margini.
- Scarsa attenzione alle condizioni materiali della produzione culturale rispetto a approcci sociologici più recenti.
Perché leggere Mimesis oggi
Perché insegna a vedere come forma e vita si rispecchino: il modo in cui una frase è costruita, chi parla, da dove, con quali parole—tutto questo è realtà storica. In un’epoca di frammenti e ibridazioni, la lezione di Auerbach sulla dignità del quotidiano e sulla mescolanza degli stili resta un orientamento potente.
Bibliografia essenziale
- Erich Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, 1946; trad. it. Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale.
- Erich Auerbach, Figura.
- Guido Mazzoni, Teoria del romanzo (per il dialogo con il realismo moderno).
“La grandezza del realismo moderno sta nell’aver accolto nella sfera del rappresentabile l’uomo comune e la sua lingua.”