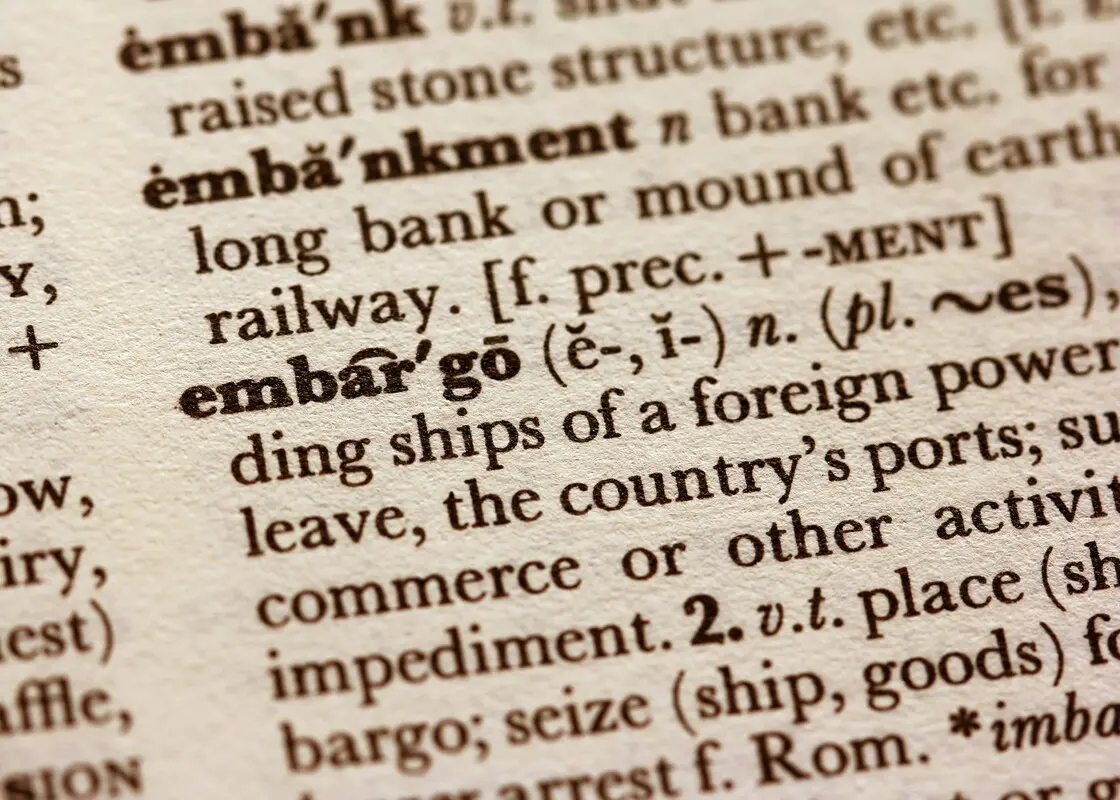Umberto Eco (1932-2016), scrittore, semiologo e filosofo italiano di fama mondiale, è stato una delle voci più lucide e influenti del panorama culturale contemporaneo. Pur non essendo mai stato un politico di professione, il suo rapporto con la politica è stato profondo e complesso, fatto di osservazione critica, interventi pubblici e riflessioni sulla società.
Un intellettuale “militante”
Eco amava definirsi un “intellettuale militante” nel senso gramsciano del termine: un uomo di cultura che partecipa attivamente al dibattito pubblico. Fin dagli anni Sessanta, collaborando con riviste come Il Verri e Il Giorno, Eco non si è limitato alla pura ricerca accademica, ma ha usato i mezzi di comunicazione per analizzare e commentare il presente.
La sua attività si è spesso intrecciata con le dinamiche politiche italiane, soprattutto nei momenti di forte polarizzazione. Negli anni Settanta e Ottanta, Eco si è occupato di propaganda, linguaggio politico e manipolazione mediatica, individuando nei media di massa sia strumenti di emancipazione sia potenziali armi di controllo.
Il “fascismo eterno”
Uno dei contributi più noti di Eco al dibattito politico è il concetto di Ur-Fascismo (o “fascismo eterno”), esposto nel saggio omonimo pubblicato nel 1995. In questo testo, Eco individua una serie di caratteristiche — culto della tradizione, rifiuto del modernismo, paura della differenza, culto dell’eroismo e della guerra, machismo, populismo qualitativo — che possono ripresentarsi sotto forme diverse in contesti storici differenti. Non si tratta di un’accusa diretta a un governo specifico, ma di un monito: il fascismo, secondo Eco, non è solo un regime del passato, ma una tentazione sempre presente.
La critica alla comunicazione politica
Eco è stato uno dei primi intellettuali italiani a studiare in profondità il linguaggio televisivo e pubblicitario, sottolineandone l’impatto sulla formazione dell’opinione pubblica. Non ha mai nascosto la sua preoccupazione per la semplificazione estrema del discorso politico, in particolare nell’era berlusconiana, quando televisione e marketing hanno assunto un ruolo centrale nella costruzione del consenso.
Celebre la sua critica alla post-verità e al proliferare di fake news, già prima dell’esplosione dei social network. Nel 2015, in occasione della laurea honoris causa all’Università di Torino, Eco affermò provocatoriamente che “i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli”, denunciando la pericolosa equivalenza tra competenza e opinione.
Un approccio da osservatore
Pur schierandosi spesso su posizioni progressiste e laiche, Eco non ha mai abbracciato un partito o una bandiera politica specifica. La sua forza stava nella capacità di osservare criticamente ogni fenomeno, rifiutando schematismi ideologici. Ha criticato tanto l’estrema destra quanto le derive burocratiche e autoreferenziali della sinistra, mantenendo una posizione di indipendenza intellettuale.
Eredità politica e culturale
Il lascito politico di Umberto Eco non è quello di un legislatore o di un attivista, ma di un interprete del nostro tempo. Le sue riflessioni restano oggi strumenti preziosi per comprendere i meccanismi della comunicazione politica, le insidie del populismo e la fragilità della democrazia contemporanea.
La sua lezione è chiara: il compito dell’intellettuale è vigilare, smontare le narrazioni ingannevoli e fornire ai cittadini gli strumenti per pensare in modo critico.